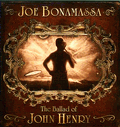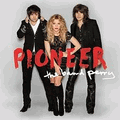recensione
|
Come posso cominciare questo pezzo? Fornendo una bio? Vi basta andare su Wiki oppure Allmusic o sul suo sito web per sapere vita e miracoli di Joe Bonamassa, quindi non sprechiamo spazio e tempo. Andiamo subito al sodo, al dunque, a quello che conta: la musica di Joe. E sgombriamo il campo da un equivoco ricorrente, che Joe in persona alimenta per un opportuno calcolo: che quella musica sia figlia degli anni ’70. Che Joe Bonamassa sia, insomma, uno dei pionieri (ha esordito nel 2000) e dei massimi esponenti del retro rock. Certo, la sua musica ha nei ’70 le proprie radici, ma – e questo è ciò che conta – viene suonata come si faceva negli anni ’80: accuratamente filtrata da una produzione raffinata (nell’album in esame, curata da Kevin Shirley), addobbata di suoni sontuosi, arrangiata senza risparmio. Non fa meraviglia che Joe abbia mollato gli indecenti Black Country Communion dopo appena tre album. Quel giochetto di riproporre tale e quale il rock di quarant’anni fa, con le stesse asprezze, lo stesso sound grezzo, campionando senza fantasia riff e assoli non poteva piacergli davvero. Lui è di tutt’altra pasta musicale.
Quando ho recensito l’ultimo ‘Different Shades of Blue’ su Classix! ho scelto come titoletto della recensione la frase: “una sicurezza”. Perché? Semplicemente perché Joe Bonamassa non ha mai fatto un brutto disco. Certi album possono piacere più o meno di altri, naturalmente. Questione di gusti personali: chi ama il suo lato più blues, chi quello più rock. Ho scelto ‘The Ballad of John Henry’ quasi a caso. Avrei potuto puntare l’obiettivo su ‘Dust Bowl’ o ‘You & Me’ o uno degli altri dischi, uno qualunque: Joe non ha mai sbagliato un tiro. Naturalmente, chi cerca l’originalità o perlomeno la novità, dai dischi di Joe è meglio che stia alla larga. Ma chi crede (e non sono pochi, al giorno d’oggi, quelli che nutrono questa convinzione, anche in ambito di critica) che per fare della buona musica rock si debba lavorare solo ed esclusivamente di carta carbone, ricopiando pedissequamente, non troverà grande soddisfazione in ‘The Ballad of John Henry’. Joe sa applicare benissimo la tecnica del copia & incolla quando vuole o lo ritiene conveniente (lo ha dimostrato ad usura nei Black Country Communion, veri principi del sampling rock), ma è un gioco che non gli interessa davvero, perché lui ha la (rara) capacità di fare del nuovo nell’ambito di quel certo sound: è un gioco sottile, ardito, raffinato. E Joe lo gioca allo scoperto, onestamente: i suoi album sono sempre infarciti di cover, con pochissime eccezioni (l’ultimo ‘Different Shades of Blue’ è composto solo di materiale originale). Ma non cover riproposte tali e quali: sia un classico del blues o del rock o del soul, vecchio come il cucco o nuovo di pacca, Joe si impossessa della canzone, la smonta e la ricostruisce da capo, a modo suo. Prendiamo la title track, che apre l’album. Sarebbe un vecchio stomp blues di Mississippi John Hurt, ma Joe prende le classiche dodici battute e le dilata in una dimensione epica (la canzone dura quasi sette minuti) alla Led Zeppelin, inesorabile e suggestiva, tramite il riff, l’arrangiamento di tastiere d’archi alla “Kashmir”, completando il tutto con un assolo fatto di note lunghe e tirate. “Stop!” fu alla fine degli anni ’80 un hit della cantante soul inglese Sam Brown: Joe immerge la canzone nel blues del Delta, la ingemma di ottoni squillanti, la marezza di fiammate elettriche, la completa con un divino finale di assoli incrociati dove la sua chitarra ha un suono caldo e suadente. Le dodici battute tornano su “Last Kiss”, sempre in versione estesa, ma più diretta, con il riff secco ed i flash di organo Hammond, sette minuti di hard blues che si concludono con il delizioso omaggio a quella struttura classica della musica del diavolo, il finale risolto solo con la chitarra acustica ed il canto a bocca chiusa. Joe affronta poi una delle canzoni ubriache e struggenti di Tom Waits, "Jockey Full of Bourbon", innestandoci un grande riff ed il piano honky tonk che la trasforma da un mambo confidenziale e sussurrato in un blues dal tempo quasi bandistico e con un flavour terribilmente New Orleans. “Story of a Quarryman” torna indietro ai primi Led Zeppelin, ma con maggior pulizia sonora, e ulteriormente addolciti da un velo di tastiere. “Lonesome Road Blues”: tre deliziosi minuti di boogie cromato e danzereccio, piano, Hammond ed una chitarra dal suono acuto alla ZZ Top. Con “Happier Times” arriviamo a quello che per me è il momento più intenso dell’album, sette minuti di pura magia, praticamente un distillato di tutto quanto di magnifico, colossale e tenero c’è nella musica dei Bad Company: il fine ordito delle tastiere, una chitarra acustica quasi spagnoleggiante, un’elettrica che taglia lo spazio sonoro come un raggio di luce, il passo lento spezzato da scoppi di energia… Ma anche “Feelin’ Good” è esemplare, la dimostrazione di cosa può fare un artista ispirato con il più semplice degli slow blues lavorando sull’arrangiamento e adottando soluzioni melodiche per nulla banali. “Funkier Than a Mosquito’s Tweeter” fu un successo di Ike & Tina Turner, e Joe fa suo questo r&b venato di funky aggiungendo allo scoppiettio degli ottoni un chitarrone che borbotta e alza la voce nell’assolo seguendo la melodia del refrain. “The Great Flood”, invece è uno slow lento e mesto, con un assolo pieno di sfumature a là Page, nella seconda parte entrano con decisione gli ottoni, un sax contrappunta la chitarra, nel finale un suono lontano di campane, tetro come un funerale sotto la pioggia. “From the Valley” sono due minuti e mezzo di chitarra acustica effettata, note che piovono lente e suggestive e se ascoltate in cuffia potete sentire appena il respiro di Joe mentre suona sul canale sinistro. Chiude “As the Crow Flies” di Tony Joe White, ancora swamp blues, ancora le dodici battute, stavolta portate nei territori del southern rock, tra una chitarra galoppante e atmosfere da film western degne della Allman Brothers Band o degli Outlaws.
C’è chi ritiene ‘The Ballad of John Henry’ il miglior album di Joe, il più completo, quello in cui la sua personalità è meglio rappresentata. Io apprezzo tutto quello che lui ha inciso a suo nome (gli infami Black Country Communion restano ovviamente fuori); anzi, per essere precisi, lo adoro in maniera viscerale, assoluta. Ritengo Joe Bonamassa uno degli artisti più interessanti degli ultimi quindici anni, capace come pochi di esplorare in maniera creativa quei territori che tanti, troppi altri percorrono come predoni, dandosi al saccheggio nella maniera più indecente e millantando poi come proprie idee il frutto di quei saccheggi. Considerato tutto questo, insistere ad associare il suo nome all’armata del retro rock diventa praticamente un insulto.
|
Chi ha soltanto sentito parlare di questa band forse penserà che il webmaster, proponendola qui, è andato fuori di testa. Ma non credo: non che i miei fedeli lettori mi ritengano a prova di arteriosclerosi e/o demenza senile, ma che abbiano sentito parlare della Band Perry. Ho verificato accuratamente e non ci sono recensioni dei due album di questi ragazzi in lingua italiana nel web. Cosa può aver allontanato la critica nostrana dalla Band Perry? Semplice trovare una risposta: il fatto che negli USA vengono catalogati alla voce “country”. Ora, il webmaster non nutre per la musica campagnola americana una gran simpatia e di questo genere, popolarissimo in USA ma praticamente ignorato fuori dai suoi confini, non si è mai interessato oltre alla lettura (svogliata) di qualche articolo su questa o quella rivista. In compenso, nutre per un altro articolo poco esportato (ed apprezzato) fuori dagli USA una passione viscerale: il football americano. E vi sto mettendo al corrente di questa passione perché è proprio grazie al football americano che mi sono imbattuto nella Band Perry. Forse saprete che durante l’intervallo fra i due tempi del Superbowl (la finale del campionato di football) viene organizzato un mega spettacolo di musica dal vivo che spesso ha visto protagonisti anche superstar della musica rock (Aerosmith e ZZ Top, solo per citarne un paio). Nel Superbowl del 2014, lo show lo fecero Bruno Mars ed i Red Hot Chili Peppers. Ma, come ogni mega show che si rispetti, c’era una band a scaldare l’audience, una band di cui non avevo mai sentito parlare, The Band Perry, un trio guidato da una bella biondina, ben dotata da madre natura anche nel comparto vocale. Guido Bagatta, che commentava la partita, non ne sapeva più di me riguardo la bella biondina ed i suoi due compagni (scoprii solo dopo che erano fratelli) e si lasciò scappare qualche osservazione più incredula che perplessa quando lesse sul programma che quella era una band di musica country. Io ero perplesso quanto lui. Perché anche a me quello che quei ragazzi suonavano sembrava imparentato con il country solo alla lontana. Il giorno dopo, andai a cercare notizie nel web e ad ascoltarmi l’ultimo album pubblicato dalla band l’anno precedente. Non ho l’abitudine di prendere nota del numero di ascolti di ogni singolo album che posseggo, ma ho la certezza che ‘Pioneer’ sia uno di quelli che hanno girato più spesso nel mio lettore CD nell’ultimo anno. Perché questo è un disco molto più rock che country. Rock moderno, alla Nickelback o Shinedown, ma – questo sì – con un innegabile gusto melodico country, una miscela che in più di un frangente richiama discretamente il southern rock (genere che può avere una forte componente country), ma su un registro diverso considerato che la produzione ed i suoni sono tutt’altro che ruvidi, anzi possiamo definirli decisamente sofisticati e non per caso, dato che ‘Pioneer’ lo ha prodotto Dan Huff. “Better Dig Two”, che apre l’album, varrebbe da sola l’acquisto: quel banjo che cigola, l’assolo di violino e l’elettricità che sale impetuosa nel refrain, quell’irresistibile ritmo da festa di campagna, ma tenuta sotto una luna abbagliante… “Done” poggia su un classico ritmo country & western, l’assolo è affidato all’armonica, è più elettrica e veemente di “Better Dig Two”, se fosse stata incisa un po’ più a sud e in chiave meno pop sarebbe southern rock puro e semplice. Il rock moderno entra in scena con “Don’t Let Me Be Lonely”, deliziosa piece melodica in minore, ma anche la title track e “Forever Mine Nevermind” – la prima, una ballad country rock delicata e intensa; la seconda, diretta e bella tosta – sono impostate sulle medesime coordinate. Si torna al più classico country blues con “Night Gone Wasted”, dura e diretta nelle strofe e melodica nel refrain, a seguire una pregevole power ballad, “I Saw a Light”, più rock che country, mentre “Mother Like Mine” è una ballad elettroacustica, semplice e tenera. “Chainsaw” ha un ritmo strepitoso, e sta nella scia di “Done”, un country rock elettrico e divertente, ma pure “I’m a Keeper” ha una bella scansione ritmica, un boogie scanzonato, come degli Halestorm in versione country. “Back to Me Without You” è una power ballad rock dal gran crescendo e in chiusura (nell’edizione standard, la deluxe edition ha altre quattro canzoni in scaletta) ci sono i bei chiaroscuri di “End of Time”.
De gustibus eccetera eccetera, dicevano i latini. Insomma, i gusti sono sacrosanti e non si discutono. Se i vostri precordi restano freddi di fronte alla musica country, forse 'Pioneer' non è fatto per voi. Ma, partendo dal fatto che i precordi del sottoscritto di fronte al country sono sempre rimasti di ghiaccio mentre la musica della Band Perry li ha notevolmente scaldati, ho creduto di segnalarli a chi, come me, ama tutto ciò che è rock melodico e probabilmente non ha mai sentito parlare di una band molto meno campagnola di quanto faccia pensare l’etichetta che gli hanno appiccicato addosso.
|
It’s only R’n’R… non saprei definire meglio la musica che i Flies On Fire suonavano su questo loro primo album (come sul loro secondo ed ultimo, di due anni successivo). Di dischi del genere ce n’è in giro una quantità abnorme, abbondano sopratutto al giorno d’oggi: allora, perché recuperare un album del 1989 quando si può ascoltarne (e gratis, magari) una dozzina a settimana del 2015, più o meno identici? Perché questo dei Flies On Fire è rock’n’roll suonato e registrato nei Big 80s, con una cura, una produzione ed una resa fonica che le produzioni attuali in genere (soprattutto in questo settore) non hanno, non possono avere perché al giorno d’oggi non si passano due o tre mesi in uno studio ad incidere, arrangiare, provare e riprovare, mancano i soldi e anche la voglia, l’album è diventato poco più di un biglietto da visita da presentare ai possibili acquirenti dei biglietti per i concerti, unico modo che le band ormai hanno a disposizione per tirare su qualche soldo… Per i Flies On Fire era diverso, l’album doveva essere bello e curato per dargli la possibilità di arrivare ai piani alti di Billboard: che non sia accaduto non ha importanza per noi che li ascoltiamo dopo più di un quarto di secolo, questo disco avrebbe potuto anche arrivare nella top ten se lo avessero spinto a dovere o la dea bendata avesse deciso di guardare nella direzione di questi quattro ragazzi yankees… Le coordinate sonore sono, come puntualizzato, tutt’altro che esotiche, “Anything Goes”, “Underground” e “You Can’t Go Back” parlano la lingua del rock americano debitamente reso heavy nella vena di (tanto per fare un solo esempio) Tim Karr, “Baptize Me Over Elvis Presley's Grave” è elettroacustica ed un po’ country; fantastica “C’Mon”, boogie blues alla ZZ Top con un bel refrain diretto ed un fantasma di armonica, mentre un sax sguscia qua e là attraverso il tessuto misterioso, notturno e fascinoso di “Small Town”. Nella seconda parte dell’album spicca una certa vena root, “Salvation Boulevard” è una ballad soul bluesy che avrebbe dovuto mandare in visibilio tutti quelli che l’anno successivo perderanno la testa per i Black Crowes, e sulla stessa rotta procedono “Not For Long” (con il pianoforte in sottofondo), “Since You’ve Been Gone” e “Let it Roll”.
Le quotazioni di ‘Flies of Fire’ sui soliti siti variano con una certa isteria dai classici quattro, cinque dollari ad oltre venticinque per copie ancora sigillate nel classico scatolotto oblungo di cartone che nei Big 80s usavano in America per vendere i CD: al prezzo più basso, è un vero affare.
|
Tutti questi vecchi (ma vecchi davvero) ronzini che invece di starsene in poltrona con una coperta sulle gambe a guardare la TV succhiando caramelle o mangiando semolino, salgono sui palcoscenici e macinano rock, a volte come e meglio di chi ha quaranta o cinquanta anni meno di loro… Il rock della terza età è un fenomeno (inevitabilmente) recente: si perpetuerà? James Hetfield o Chad Kroeger li ritroveremo chitarra a tracolla su un palco a settant’anni? Non so se sperarlo o temerlo… Questi Hundred Seventy Split sono degni rappresentatnti della ormai foltissima categoria, annoverando tra le loro fila Leo Lyons, storico bassista dei Ten Years After, classe 1943. Il loro hard blues, naturalmente, è rimasto fermo a quanto nel rock era “in” e “cool” nel 1970 o giù di lì. Onesto? Senza dubbio. Stantio? A tratti. Già sentito? Praticamente fino all’ultima nota, come il 98% del retro rock in circolazione. Se avessero insistito sulla strada tracciata da “Gravedigger”, con le sue belle sfumature jazzy alla Steely Dan, le possibilità di distinguersi almeno un po’ dalla concorrenza sarebbero aumentate, invece hanno preferito cucinare quasi tutto questo ‘Tracks’ seguendo la solita ricetta, e pur con tutte le guarnizioni folk, stoner e blues, non è strano che nel piatto abbiamo finito per trovarci la solita minestra: non che il sapore della pietanza sia brutto, solo è difficilissimo distinguerlo da quello delle centinaia di pietanze analoghe servite da band vecchie e giovani tutte prese a replicare la musica di un decennio mitizzato oltremisura.
|
Speravo di cavarmela con una recensione breve, ma non sono riuscito a compendiare efficacemente il mio pensiero sul secondo album degli Inglorious. È tanto difficile, penserà qualcuno, dire se un album è buono, sublime, noioso o ributtante? Sì, in certi casi. E questo è proprio uno di quei casi. Mentre ascoltavo le prime canzoni di ‘II’, l’impressione che ne ricavavo era negativa, ma mano a mano che l’album procedeva trovavo sempre più difficile prendere appunti, abbozzare un commento: la musica mi aveva preso al laccio. Eppure…
Da dove possiamo cominciare? Il confronto (ineludibile) con il predecessore dell’anno passato? ‘II’ è un deciso passo avanti: rinunciando alla frastornante aggressività metallica dell’esordio, la band ha guadagnato in gusto e forza espressiva. E le canzoni? Il suono degli Inglorious oggi è chiuso in un quadrato di riferimenti preciso come se l’avesse tracciato un geometra: Whitesnake, Led Zeppelin, Rainbow, Deep Purple. Punto e basta. E le canzoni sono tutte straordinariamente efficaci, nel senso che ci danno una piacevole sensazione di familiarità senza mai scadere nel copia & incolla più inverecondo: sono variazioni su temi e atmosfere che conosciamo a menadito ma variazioni, ribadisco, efficaci. Tutto bene, allora? Potremmo dire di sì. Tante band che nel passato remoto o recente abbiamo mandato alle stelle hanno operato allo stesso modo degli Inglorious: i Badlands ed i Burning Rain, tanto per fare due nomi. Eppure… C’è qualcosa, qui, che nonostante tutto mi fa sentire un po’ a disagio. Questa band è senza dubbio enormemente cresciuta, ma sembra che abbia messo il proprio talento solo al servizio del passato. E in tutte queste dodici canzoni non c’è niente di personale, niente che porti un minimo segno che dica: questa roba l’abbiamo fatta noi. E questo non mi piace per niente. Si può guardare al passato ed avere un proprio sound, una propria identità sonora: pensate ai Red Sky Mary (li ho recensiti su Classix un paio di anni fa). Ma poi, abbiamo davvero bisogno di un’altra versione dei Badlands o dei Burning Rain? Ha senso continuare imperterriti a girare attorno a quei soliti temi, a rimestare in quella pur saporita minestra sperando di tirarne fuori altri bocconi ghiotti? Non è che quei sapori mi siano venuti a nausea, tutt’altro, ma quando vedi una band così giovane e talentuosa ficcarsi in quello che è in fondo un vicolo cieco, impegnare tutto il proprio ingegno per replicare quanto si faceva quaranta e passa anni fa… Non è questa la strada giusta per tenere vivo il classic rock. ‘II’ ha tutto per mandare in visibilio i cinquantenni nostalgici come il sottoscritto, ma chi guarda anche al futuro del nostro genere non può non sentire un campanello d’allarme nel proliferare di proposte come quella degli Inglorious. Se una forma d’arte non muta e si adatta ai tempi, se non trova qualcosa di nuovo da dire, si fossilizza e muore. Non possiamo pretendere novità dai Rolling Stones, ma dalle band giovani sì. E qui abbiamo una band giovane e senza il minimo dubbio con un grande talento. Ma come lo impiega, questo talento? A replicare, sia pure in maniera eccellente, quanto altri facevano quando alcuni di loro neppure erano nati.
Ecco da dove nasce tutta la mia perplessità, il mio sconcerto. ‘II’ mi piace ma mi lascia uno strano sapore in bocca. Sento che questa band potrebbe fare qualcosa di buono, forse addirittura qualcosa di importante, e invece preferisce rimanersene confinata nel recinto di cui sopra, rimbalzando dall’uno all’altro dei suoi quattro lati, girando in tondo. Spero che trovino la forza ed il coraggio di spezzare gli steccati in cui si sono reclusi e avventurarsi fuori da quello spazio angusto, perché il rock ha bisogno di artisti capaci e desiderosi di rompere i muri, non di innalzarli: di nuovi Cream e Rolling Stones e Jimi Hendrix, non degli ennesimi Thunder. E ‘II’ sembra dirci che gli Inglorious, purtroppo, hanno deciso di barricarsi nella stessa prigione in cui da trenta anni i Thunder sono ospiti felici e soddisfatti.
|
Quando, nel 2012, Ronnie Montrose lasciò (di sua iniziativa, come noto) questa valle di lacrime, stava lavorando ad un nuovo album che avrebbe dovuto intitolarsi ‘10X10’, perché avrebbe dovuto essere composto da dieci canzoni cantate da dieci cantanti diversi. La tragica morte di Ronnie sembrava aver messo la parola fine anche a ‘10X10’, che invece riemerge dopo cinque anni grazie a Ricky Phillips, il quale ha completato l’opera secondo quelli che furono gli intendimenti del suo ideatore grazie ad una strepitosa parata di ospiti ed a Eric Singer sempre presente alla batteria.
“Heavy Traffic” apre con un classico hard rock anni ’70 cantato da Eric Martin, con Dave Meniketti ospite alla chitarra, mentre sullo slow blues “Love Is An Art” risalta soprattutto il bel dialogo tra il sax di Edgar Winter e la chitarra di Rick Derringer. “Color Blind” è un eccellente mix bluesy di potenza e atmosfera con un grande Sammy Hagar al microfono e Steve Lukather alla chitarra, ma anche “Still Singin’ With The Band” spicca, col suo bel riffone zeppeliniano, il retrogusto funk e le vocals soul di Glenn Hughes, l’armonica di Jimmy "Z" Zavala e la chitarra di Phil Collen. Altra perla è “Strong Enough”: sinuosa, con la chitarra di Ronnie che qui ha un suono caldo e sporco e la voce sempre magnifica di Tommy Shaw. “Any Minute” è serrata e molto anni ’70 e non per caso è stata affidata alla voce di Mark Farner, mentre Ricky Phillips si incarica delle vocals della bella “The Kingdom’s Come Undone”, notturna e selvaggia, dove troviamo Joe Bonamassa alle prese con una stesura in bilico tra le cose più cerebrali di Billy Squier ed un prog alla Yes rivolto in chiave hard rock. A seguire, due avvincenti cavalcate, “One Good Reason” cantata da Bruce Turgon e ritmata dalla chitarra di Brad Whitford e “Head On Straight”, che viaggia su un riff di nuovo molto Zep ed è arricchita da un break di tamburi tribali su cui si dipana l’assolo. Chiude “I’m Not Lying”, che parte sognante e si fa calda e r&b nella seconda parte, con il sax di Tom Gimbel, l’Hammond di Larry Gowan ed i fiati che salgono in un crescendo orchestrale nel finale sotto le vocals di Greg Rolie.
‘10X10’ è senza dubbio un sentito omaggio alla memoria di Ronnie Montrose, chitarrista sottovalutato quant’altri mai, ma anche un bellissimo album che merita di essere apprezzato in sé, indipendentemente dal fatto di costituire l’ultima testimonianza delle qualità di Ronnie come strumentista e compositore.